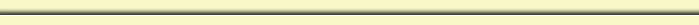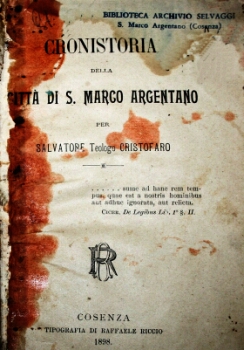>
IL BARONE DI VALLESCURA
(Commento critico di Pasquale Candela)
Il poeta toccava allora il ventunesimo di sua età. I tempi volgevano tristi e sconfortanti per la patria nostra. Lo spirito dei fieri Calabresi pareva prostrato sotto l'incubo del servaggio. Il terrore aveva invaso quelle anime ardenti e amanti di libertà. Il poeta si ricordò di una pagina gloriosa della nostra storia, quando il feudale regime, ergentesi orgoglioso sulle miserie dei popoli, simile ai castelli che torreggiavano a fianco dei poveri ed umili abituri, dopo sette secoli di oppressiva potenza, cadde per la diffusione delle nuove idee di civiltà e di progresso.
I Baroni,dice uno storico,avevano conquistato la nazione; fu poscia la nazione, quella che conquistò i Baroni. Forse in veruna parte d'Italia, la tirannide feudale aveva esercitato tanta signoria, quanta nelle Calabrie, e quindi nessun popolo più del Calabrese contribuì pure a scrollare quel vergognoso edifizio della superbia umana.
Quale riscontro di tempi e di vicende, di oppressori e di oppressi,d'infamie e di delitti,di lotte sanguinose, di barbarie e di risorgimento nella vita del nostro popolo! Al poeta lampeggiò un'idea; e, quasi che presentisse il novello sorgere de' tempi concepì il disegno di svolgere in cinque drammi questa lotta vigorosa e perenne de' diritti d'una Nazione avverso le ingiustizie della prepotenza.
La morte che immaturamente lo colse spezzò l'orditura di un sì vasto concetto; e fu per noi irreparabile sventura l'aver perduto nel poeta nazionale uno di que' Geni che si sollevano all'altezza dei tempi e de' bisogni sociali.
Nondimeno, quel che rimane può bastare a farci avere un'idea dello scopo cui mirava il Selvaggi.
Nel dramma "Il Barone di Vallescura",appena sbozzato e tuttavia inedito, il poeta mirò a svolgere le cause morali, che produssero la caduta del feudalismo, reso ormai incompatibile con lo svegliarsi del sentimento nazionale di que' tempi; e nel fatto stesso del Feudalismo intese ritrarre la caduta inevitabile d'ogni dispotico potere,il quale manometta e conculchi i diritti e la dignità di una Nazione.
A conseguir questo scopo doveva egli scegliere un'epoca né troppo lontana all'agitarsi delle nuove idee, né troppo vicina al compimento di quegli avvenimenti, che ebbero luogo in quell'epoca veramente gigantesca di politici rivolgimenti. doveva mettere in azione personaggi e caratteri, che rappresentassero un fatto non già parziale ed individuale,ma bensì generale collettivo; un fatto che ritraesse la lotta fra due opposti principi, fra due forze rivali, fra due civiltà, vecchia l'una e crollante, nascente l'altra e vigorosa.
Ora il 1783 si offeriva appunto come un'epoca di ribollimento universale, in cui la fisica e la morale natura, commovendosi, perturbandosi, scolvolgendosi, preparava uno di quei grandi cataclismi sociali, che sono indelebili nella memoria dei posteri; cataclisma il quale aveva poi il suo compimento nel gran fatto del 1789 per la propagazione dei nuovi principi, ed in quello ancora del 1806, per l'abolizione totale del Feudalismo, in virtù della nuova legge.
Cotesta epoca del 1783 era dunque l'unica e sola, atta ad incarnare l'idea di siffatto dramma, come quella che segnava una linea di transizione tra il cader dei vecchi tempi ed il sorger dei nuovi, e porgeva la opportunità di dare svolgimento all'azione in Calabria e la sua durata estendersi dal marzo al maggio del I783.
Noi gli sappiamo grado di tale avvertenza, perché ci metteva in mano la chiave del suo concetto. Ma quando anche non l'avesse fatto, noi lo avremmo dovuto trovare nel corso stesso degli avvenimenti, nella natura caratteristica dei personaggi, nella lotta delle loro passioni, nel complesso insomma di tutte le circostanze, che possono dare movimento e calore ad una drammatica rappresentazione.
In ogni opera drammatica due vie sono aperte al poeta: o prendere dalla storia l'azione principale e vestirla di finzioni fantastiche; ovvero collocare un'azione finta in mezzo a particolari storici.
Il nostro poeta si attiene alla prima, perché egli doveva incarnare il suo disegno in un fatto, in un avvenimento, grande nella storia del nostro popolo, quale si fu appunto la storia del Feudalismo, non già un fatto parziale e staccato, quale sarebbe stato la caduta di questo o di quel Feudatario.
Il Feudalismo minacciò sempre di cadere, perché le angherie di questo patronato oppressivo, imposto ai popoli, rese ognora insopportabile uno stato di cose così contrario alla loro indole, e alla stessa unità del politico reggimento; nulladimeno esso non cadde definitivamente se non quando le idee di libertà furono mature e la sovranità fu stanca delle usurpate attribuzioni; quando il Feudalismo cessò di essere una tutela dei popoli e diventò invece una minaccia per il legittimo potere; il che avvenne senza dubbio tra il I783 e il 1806.
Ciò non è che storia, e questa storia fa sì che noi leggendo il dramma del Selvaggi riferiamo tutti gli avvenimenti a questa unica epoca, la quale costituisce appunto il tempo dell'azione.
La storia ci dice ancora che un tale Enrico Kalà, duce Svevo, fu da Enrico IV°, imperatore di Germania, investito di vastissimi Feudi, e che egli tra gli altri ne possedeva uno in Martorano detto Valle Oscura.
Ecco un altro fatto che costituisce il luogo dell'azione e la circoscrive in Calabria.
Con questi dati storici di tempo e di spazio, il poeta ordisce la tela del suo dramma collocando in modo gli avvenimenti, che mentre qusti si aggirano nella loro fantastica idealità, mostrano ad un tempo lo sfondo del quadro, e i personaggi posti in azione diventano simboli e personificazioni di una grande idea, di un avvenimento interesante di un'epoca memoranda.
Quindi è che colorandosi a poco a poco il concetto dell'artista, riluce la lotta tra l'antica barbarie e la novella civiltà, tra gli ultimi conati del cadente Feudalismo e l'affacciarsi di un'età piena di vita, di speranza e di gloria.
E il lettore, percorrendo il dramma, coglie appunto questo concetto asportando i personaggi immaginari sul campo della storia, che si para davanti e fa sì che al fatto s'incarni l'idea, e fatto ed idea, collegati fra loro, si spiegano a vicenda e tutto diventa chiaro, armonico, compiuto.
In tal modo la storia e la poesia si sostengon l'un l'altra, e l'azione riesce bella ed interessante: bella come un'opera d'arte, interessante come ricordo al nostro popolo di un fatto glorioso, spingendolo ad imitare que' generosi avi che scossero un tempo ed atterrarono la secolare potenza dei loro oppressori.
Ma seguiamo l'autore medesimo nello svolgimento del suo dramma, per vedere se egli raggiunge lo scopo, che si era proposto.
La scena si apre con la comparsa di Ernesto, barone di Vallescura. Costui è agitato da un doppio sentimento, il rimorso e la paura. Questo doppio sentimento non può essere altro se non un simbolo del passato e dell'avvenire: del passato che ha aperto l'abisso della sua morale rovina; dell'avvenire, che va scalzando le basi della sua secolare grandezza.
Egli sa che deve cadere perché mal può reggersi a fronte di un avvenire senza speranza.
Ultimo rampollo di una stirpe, da lui stesso esecrata, non ha alcuno al mondo che gli sia legato per sangue ed a cui possa trasmettere il suo avito retaggio, la sua potenza, la sua nobiltà, la sua ricchezza, il suo nome; tutto finisce con lui! Nel sociale abbandono in cui vive, chiede pace alla terra, ma l'odio degli uomini, trasmesso per sette generazioni, sta addensato sul suo capo, scritto sulla sua fronte, e tutti s'involano a lui, come al maledetto da Dio!- Unica ancora, cui sta sospeso, tuttavia, il debil filo, che tienlo attaccato alla vita, è la vezzosa Elisabetta, vergine trilustre, cui un tempo il vecchio e fido Ansaldo, in una notte d'incendio e d'isterminio per la famiglia di Corvonero, dal potente signore perseguitata, rapiva al proprio padre per metterla fra le braccia del Barone, e nascondergli così la perdita dell'unica figliuola, che si moriva poco dopo la morte della giovine sposa.
Ma il tempo ha pur tolto il velo di questo inganno pietoso, ed egli acquista la dolorosa certezza che la sua stirpe si estinguerà con lui, come l'ultimo sospiro del moribondo.
Elisabetta non è sua figlia! Nondimeno, all'affetto di padre è subentrato quello di amante, ed il suo cuore i consuma per occulto, inestinguibile fuoco, e tutta la sua esistenza si chiude in questo vergine fiore, che una mano amica par gli abbia fatto cadere in mezzo al deserto della vita.
Egli non possiede attualmente altro bene sulla terra, tranne quest'amore pudico, innocente, santo vorrebbe egli, l'esoso feudatario, purgare il vergognoso passato, rigenerarsi nella vita degli affetti, riabilitarsi con la società oltraggiata, diventare insomma un altro uomo, ritornare fanciullo.
E il suo cuore si culla tra le ridenti immagini della fanciullezza, quando l'armonioso canto della sua Elisabetta si sposa al suono della cetra, toccata dalla mano di lei.
Allora si acquetano in lui gli spirti procellosi, ed egli tremante e pentito par che dica alla nuova età: aspetta non affrettare la mia caduta! Ma no, la nuova età non può venire a patto con un passato abominevole! I tiranni giurarono sempre a fronte del pericolo e parvero pentiti; ma presto si ridestarono gli istinti feroci, e tornarono tiranni. E nel pentito Barone non tarderanno questi istinti a ridestarsi.
Elisabetta, simbolo di quest'età novella, che si affaccia ridente di speranze e di libertà, ama la vita libera e aperta dei campi. Essa ha veduto il giovane Arrigo, e il suo cuore si è già dischiuso al palpito dell'amore. Essa non può amare il vecchio Barone, e, quantunque il creda suo padre, pure agitata da un arcano presentimento, schiva della vita solitaria e sospettosa di lui, s'invola alle sue carezze, s'invola alla tetra e paurosa maestà di quel superbo castello, per ispaziare, volante farfalla, tra gli umili fioretti dei prati.
Ernesto la segue con l'occhio torvo e sospettoso, col cuore che gli presagisce una sventura: egli perderà la sua Elisabetta! Corvonero: mi fu da lui medesimo tolto e moglie e figli e sostanza e patria, Corvonero, stà lì nei boschi, formidabile bandito a meditare la sua vendetta.
Fu tempo in cui il suddito s'inchinava ubbidiente dinnanzi all'arbitra volontà del suo Signore, ora è il signore che trema dinnanzi al servo, che ha spezzato le catene: Corvonero con la banda de' suoi compagni d'armi i quali fanno sentire l'inno di libertà in mezzo ai boschi, con la popolarità che gode presso gli stessi sudditi del Barone,, rappresenta la rivoluzione armata.
E' il popolo che stanco delle sue sofferenze, impugna le armi e grida: Avanti! E mentre offre il petto al furore del tiranno e paga col sangue il suo coraggio, spiana il cammino ad un nuovo ordine di cose, e scrolla le basi del dispotico potere.
Il Barone impallidisce al nome di Corvonero; si sa che la vittima designata è la sua Elisabetta, che rapirà come a lui egli rapiva ogni cosa! Crede che colui, il quale dovrà tradirlo, sia Ansaldo. Oh! il terribile sospetto, che gli rode le viscere, e che non valgono a dileguare le nuove e tenere proteste di fedeltà del vecchio servo. Chi potrà chiarire il tenebroso arcano'
Un essere misterioso si nasconde nel seno di una cavernosa montagna; parla con gli astri, comunica con gli abissi, si avvolge nel turbinio dei venti e delle tempeste. E' la strega del noce di Benevento!
Tutti fuggono da lei, segnandosi spaventati. Eppure essa un tempo era una donna stimata. Il voluttuoso volse gli occhi sulla di lei figlia, ch'era vergine e bella, e con simulato matrimonio, indusse la infelice a cedergli l'onore della pudica! Poscia sazio di voluttà, abbandonò madre e figlia all'infamia...! Ahi! la tradita smarrì la ragione, ma la madre oltraggiata vendette l'anima sua all'inferno, e giurò di vendicarsi.
La pazza e la strega, ecco due simboli dei mali che produce la tirannide; l'abbrutimento intellettuale e morale della società, la quale poi si vendica con gli atti feroci della sua stessa brutalità! Terribile lezione a que' grandi della terra, che riducono i popoli eccessi della pazzia.
Povera Caterina! ella si crede ancora la moglie del suo Signore, e, aggirandosi intorno al castello di lui lo incalza col grido della pietà e del dolore. D'altra parte la strega, tremenda sacerdotessa d'inferno, sente che già s'appressa l'ora tanto attesa della vendetta poiché stanno già per compirsi i destini del tiranno.
L'occasione è venuta, l'inferno le arride. Il sospetto, il timore,la superstizione sospingono il Barone alla stessa grotta della maliarda, ed egli viene a lei per consultare i suoi oracoli.
Oh! la gioia infernale di questa donna inesorabile. Oh! il suo canto di una terribile sublimità! Il Barone ode questa nenia satanica e s'appressa, quasi tratto da una forza ignota, con le chiome irte e col cuore in tempesta.
Sciagurato! Ei non sa che s'appressa all'orlo del suo fatale abisso. Un nuovo delitto è quello che vede pesare sulla bilancia dell'eterna giustizia dei popoli!
La strega legge nel reo cuore di lui, e fa sentire il suo oracolo di morte.
Ansaldo è il traditore! Oh, la tremenda parola, che sconvolge tutta l'anima di Ernesto.
Nell'accecamento del suo furore sente egli ridestarsi in un istante gli istinti di sangue e Ansaldo, il misero Ansaldo, l'uomo del popolo, il vecchio padre di latte, l'unico amico che a lui restava in tanto odio universale, Ansaldo cade vittima innocente di un vile sicario.
Ansaldo simboleggia l'ultimo avanzo del vassallagio feudale. Morto lui, non resta che la nuova generazione,rappresentata in un coro di fanciulli, i quali già incominciano a manifestare idee e sentimenti di libertà e d'uguaglianza, a scuotere il giogo del dispotico potere. Ma la strega non è contenta di aver trascinato l'esoso barone ad un nuovo atto di tirannide per affrettarne la caduta. A lei non basta di avergli suscitato contro la universale esecrazione.
E' necessario che alla caduta morale segua la materiale distruzione; è necessario che egli perda il baluardo della sua potenza. Ed ecco la banda di Corvonero, simbolo della popolare vendetta, che istigata dalla strega, mette fuoco al castello, il quale, preda delle fiamme, cade in ruina.
Il Barone giunge a salvarsi, ma la sua Elisabetta viene nelle mani del suo nemico.
Intanto nell'atto di sfogare la sua vendetta sulla innocente, giunge a scoprire che essa è sua figlia, perduta in quella notte d'incendio e di isterminio per la sua famiglia. Un incendio gliela rapiva, un incendio gliela restituisce.
Oh! la gioia di quel cuore, che solo per vendicare il sangue de' suoi, strinse per tanti anni l'arma del bandito e visse nei boschi vita d'affanni, di odi e di timori.
Corvonero è il vero tipo del bandito calabrese che si gitta in mezzo alle selve non per mestiere, ma per vendicare contro gli oltraggiatori, per reagire contro una società egoista ed orgogliosa!- Però la gioia di Corvonero non è di lunga durata. Egli viene arrestato in mezzo al suo trionfo dai soldati della legge, perché se il Feudalismo è caduto moralmente in Ernesto, e materialmente nella distruzione del suo castello, la legge non ha ancora sanzionato la sua caduta.
Le rivoluzioni non sono che un atto violento, un disordine, una rappresaglia della società offesa ne' suoi diritti; ma infine è la legge quella che si fa riparatrice delle umane ingiustizie, ristabilendo l'equilibrio e l'armonia de' diritti e de' doveri sociali.
Corvonero giace dunque in oscura prigione, mentre Elisabetta è stata rimessa nelle mani del Barone.
Ma non per questo gode costui del suo trionfo,imperocché se egli ha riacquistato la sua Elisabetta, ha perduto nel tempo stesso tutta l'illusione del suo amore.
Egli non ha più diritto sul cuore di lei; essa è la figlia di colui che geme tra ' ceppi, vittima infelice dell'odio e delle persecuzioni di un uomo che tiranneggiò e spense una povera ed innocente famiglia. Nonché al cuor di lei : non può aver pretensione neppure ad un sentimento di riconoscenza! Oh! la desolata Elisabetta! Nella tenerezza del suo filiale amore fa ogni forzo per salvare il misero padre dalla vendetta del fiero Barone, che omai ella odia ed aborre! Questi però l'ama ancora, e tutto, tutto darebbe per meritare il di lei amore. E perché tra lui e la fanciulla evvi un abisso che li separa; egli sarà felice, purché gli resti l'ombra di questo amore!
purché la fanciulla non si allontani da lui! Lacrimevole situazione di un cuore, che sente di essere abbandonato da ogni umano affetto! Ei non sa che fare per guadagnarsi un solo sorriso dell'amata Elisabetta! Non ama ella un miserabile vassallo, il giovane Arrigo, povero d'ogni bene di fortuna'
Ebbene se l'abbia pure Arrigo! Fu tempo in cui egli avrebbe schiacciato l'audace che avesse osato volgere uno sguardo sulla sua Elisabetta!
Ora egli stesso, il geloso, il terribile barone, cede lei, l'amor suo, l'oggetto d'ogni sua delizia al proprio vassallo, e con lei tutto il suo retaggio! Non vuole ella che il padre suo, il nemico di lui, Corvonero sia salvo ' Ebbene che Corvonero sia libero e sciolto, che parta, che fugga da lui, che viva lontano da lui! Infelice Ei dunque non ha più amico, non castello, non retaggio, non amante! Tutto, tutto è perduto per lui!
In questo totale abbandono egli si volge a Dio e gli chiede la pace del cuore! Ma la sua parola è senza fede, la sua preghiera stessa è un insulto alla Divinità, il suo grido, il suo gemito è quello del dannato senza speranza!
Oh! il tiranno non sa pregare: è il timore che lo muove, non ha fede.
Egli esce dal tempio dove giace Corvonero. Il carnefice è dinnanzi alla sua vittima.
Questa scena straziante, quale contrasto d'affetto e di carattere tra un cuore nobile, ripieno di paterna tenerezza ed un'anima esacerbata dall'odio degli uomini! Corvonero, vedendosi dinnanzi il Barone non pensa che alla sua figlia, cui vorrebbe stringere, un'altra volta, fra le sue braccia; egli in quel momento, non vede che l'angiolo della sua vita; egli dimentica il tiranno e perdona! Prostrato ai piedi del suo implacabile nemico, implora pietà perché gli venga restituita la sua Elisabetta! Ma il tiranno' Oh! il tiranno non dimentica mai! Sul suo volto lampeggia una gioia feroce, perché in quel atto d'umiltà e di sottomissione crede di essere ancora potente: sentesi divenuto un'altra volta il temuto signore di Vallescura! Il suo cuore è gonfio d'orgoglio, egli non pensa più all'amore perduto, alle ricchezze cedute, all'odio cui è fatto segno!
Gli sta innanzi tutto un passato non per rinfacciargli i suoi delitti ma per rendergli la coscienza della sua grandezza. Insensato! l'ora della sua caduta è suonata! Egli non è che l'ultimo raggio di un astro funesto che sta per eclissarsi ed estinguersi!
La pazza torna a girargli attorno: torna ad incalzarlo col suo canto di morte! La terra si scuote dalle fondamenta, ed il terremoto del I783 ravvolge nella sua ruina montagne, città e popoli!
Oh! lo spettacolo d'orrore per quel uomo che vede se stesso e la sua potenza, ravvolti nell'ira della natura e di Dio!
La strega, la implacabile strega, cammina su quelle rovine e scioglie l'ultima nenia alla caduta del comune nemico. ormai l'azione è in su lo scioglimento. Tutti i personaggi si aggruppano. Un tribunale è eretto a giudicare Corvonero. Da una parte sta la tirannide, che ha sete di nuovo sangue: in lei si sono ridestati i segni dell'antica ferocia! Dall'altra sta la legge, tuttavia, tentennante e risoluta; essa non ha ancora spazzato dalla società questo ingombro molesto, che costituisce un potere nel potere e manomette il diritto di uguaglianza infamia alla stessa legge.
Oh! il momento solenne, in cui la feudale tirannide lotta con la legge che deve colpire. Da questo momento dipendono le sorti dei popoli!
O la tirannide aristocratica con tutti gli orrori della miseria; o la eguaglianza sociale con tutti i privilegi della libertà! Chi farà piegare la bilancia da questa o da quella parte' Ecco la voce di Dio! Ecco la parola di quella Religione, che stabilì sulla terra l'eguaglianza degli uomini,che illuminò le menti, che combatté la superbia dei potenti, e rialzò la dignità dell'umana natura! Ecco un santo Eremita, il quale si frappone tra il diritto e la forza, tra l'innocenza e l'arbitrio, tra la vittima e il carnefice. Egli è il profeta di Dio; la sua parola è ispirata. Egli annunzia la nuova età che sta per sorgere!!! Il suo fatidico pensiero vede già un popolo di Eroi che scende, qual fulmine, dalle nevose Alpi e viene ad affrancare i popoli dall'antico servaggio!
Ma mentre egli fa balenare in faccia al tiranno la vindice folgore della divina vendetta; mentre arresta la mano ai giudici; mentre resiste al Barone, che fremente di sdegno sta per compiere un ultimo atto di feroce dispotismo; ecco annunziargli che Corvonero è già fuggito co' suoi banditi; Arrigo ed Elisabetta abbandonano per sempre quel misero avanzo della feudale potenza; gli stessi soldati della tirannide gittano via le armi, una lotta s'impegna tra il bandito ed il Barone, una palla gli spezza una spada in mano: il Barone è vinto!! Tutto è finito il feudalismo non è più!!!
Ecco delineato un quadro di questo dramma grandioso. Ci è stato forza percorrerlo parte a parte, sebbene rapidamente, perché se ne potesse avere un giusto concetto, essendo un'opera tuttavia inedita.
PASQUALE CANDELA
S. Marco Argentano, 3O ottobre 1870